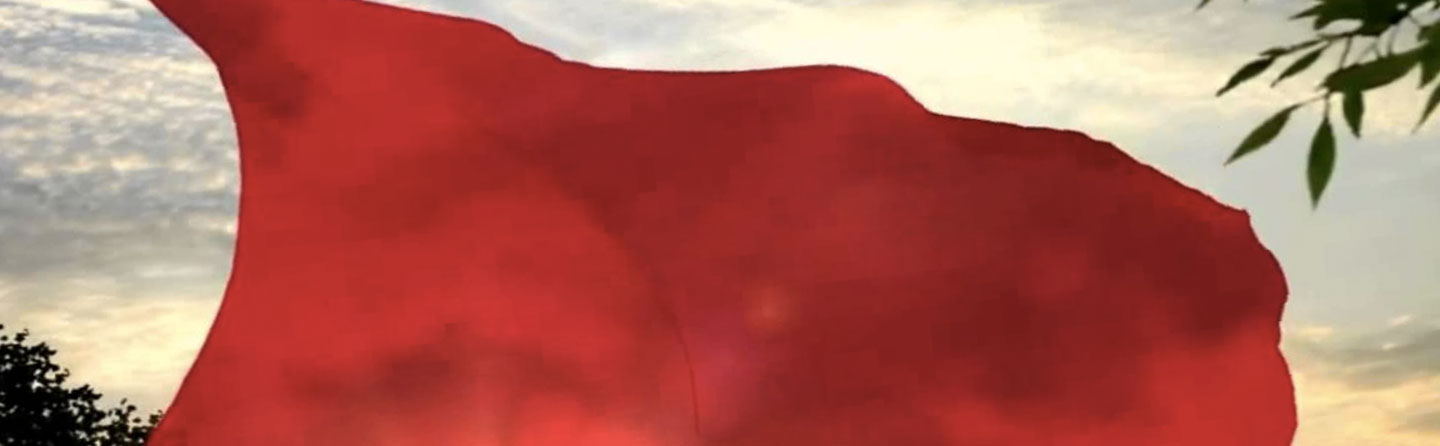C’è ancora un futuro per il “sindacato generale” incarnato dalla CGIL nel corso del ‘900?
La domanda può apparire sorprendente per chi dia per scontata l’identità e la funzione del principale sindacato confederale del nostro Paese, ma molti elementi ci invitano a non sottovalutare la questione. Che non riguarda solo il destino di una organizzazione, ma anche il ruolo che nel futuro di questo nostro Paese potranno giocare la rappresentanza del lavoro e le forze che si richiamano ai valori della sinistra.
I segnali che portano a rispondere con pessimismo al quesito mi sembrano evidenti, li richiamerò dunque nei termini più brutali. D’altra parte le esigenze che sollecitano una risposta positiva sono profonde per chi senta la necessità di uno sviluppo più sostenibile dal punto di vista sociale ed ambientale. Questa è la traccia della riflessione che, con un po’ di incoscienza, intendo proporre, ben consapevole del fatto che chi scrive ha una formazione ed una esperienza limitata, e che l’idea del sindacato “generale” (cioè con un ruolo politico, non partitico, che travalica la funzione strettamente sindacale) è tutta italiana, quando invece le sfide dello sviluppo hanno dimensione globale.
Ho fatto riferimento alla storia. Permettetemi dunque di richiamare alcuni episodi che testimoniano il ruolo “politico” (dunque “generale”) esercitato dal principale sindacato italiano, e ne hanno fatto una esperienza molto particolare nell’ambito del movimento sindacale internazionale.
La Confederazione Generale del Lavoro nasce nel 1906 aggregando realtà tra di loro assai diverse unite da una comune aspirazione: conquistare per il lavoro tutele da sempre negate. Partecipa da protagonista al processo che porta grandi masse popolari ad entrare per la prima volta nell’arena democratica e politica. Le Camere Confederali del Lavoro, riprendendo l’esperienza francese, aggregarono strutture rivendicative (le leghe territoriali e le categorie professionali) e strutture mutualistiche (cooperative, società di mutuo soccorso). Videro la partecipazione dei lavoratori della terra che volevano uscire da condizioni di servitù, di lavoratori della nascente industria che scoprivano la forza rivendicativa data dalla comune appartenenza ad una condizione “di classe”, e lavoratori professionalizzati che oggi collocheremmo nel lavoro autonomo (fornai, calzolai, artigiani…). Si intrecciarono così esperienze rivendicative, mutualistiche ed organizzative che portarono ad una rappresentatività molto forte in contesti diversi: nel sud feudale come nel nord mezzadrile, nelle nuove industrie come nei vecchi cantieri navali. La forza rivendicativa di matrice sindacale e quella organizzativa di tipo mutualistico e cooperativo alimentarono lo sviluppo di rappresentanze politiche nell’ambito della cultura socialista e cattolica. Non a caso proprio su queste organizzazioni si abbatté la reazione fascista, che si accanì distruggendo le Camere del Lavoro e le Leghe territoriali, impose un assetto corporativo alle categorie e legò al nuovo regime (pena la chiusura) le cooperative.
Il crollo del fascismo fu accompagnato dal riemergere del protagonismo sindacale nelle grandi fabbriche, ove la mobilitazione dei lavoratori per la fine della guerra fu decisiva per ridare fiducia all’antifascismo già nella primavera del ’42 e poi del ’43. E l’azione di salvaguardia degli impianti produttivi minacciati dall’invasore tedesco indicò una diffusa propensione a considerare il futuro del Paese come un “affare proprio”, non delle sole classi dirigenti (per altro ampiamente screditate per la sudditanza al regime fascista). Analoga la vicenda vissuta dalle campagne, con lo sviluppo (nel nord) di una lotta partigiana che si intrecciò ampiamente con la ripresa dell’iniziativa nei confronti della proprietà agraria, anch’essa assai legata al regime fascista.
Le forze politiche che animarono la resistenza videro quanto importante fosse il ruolo dei lavoratori per la libertà e per lo sviluppo futuro del Paese, ricostituirono dunque un sindacato unitario e pluralista (dunque tendenzialmente autonomo dai singoli partiti) e con la nuova Italia repubblicana scrissero una Costituzione che fondò “sul lavoro” l’aspirazione ad un Paese più giusto e prospero. Sul lavoro, perché né la vecchia aristocrazia, né la chiesa cattolica, né la lingua italiana erano nelle condizioni di unificare una nazione come l’Italia. La scelta di fondare “sul lavoro” la Repubblica fu votato da tutti, dalle destre liberali al partito comunista, e fu accompagnata dalla volontà di fissare nella Costituzione principi di tutela del lavoro che richiamavano con nettezza il riferimento non solo al valore dell’impegno professionale ma anche al valore della rappresentanza sindacale.
Con la frattura tra le forze antifasciste questa rappresentanza si ruppe, ma la sua natura confederale (quindi tendenzialmente non corporativa) venne salvaguardata sia dal mondo cattolico che dalle forze laiche, socialiste e comunista. Non mancò l’attenzione a promuovere, insieme al miglioramento delle condizioni di lavoro, anche lo sviluppo del Paese, ma le tre confederazioni scelsero strade parzialmente diverse: Cisl e Uil la via del confronto nell’ambito delle singole aziende per condizionare le strategie imprenditoriali, mentre la Cgil decise di accompagnare l’azione contrattuale con la proposta di un “Piano per il Lavoro” volto ad intervenire su ritardi e limiti storici dell’Italia. Una strada ambiziosa, sostenuta anche con forme di lotta innovative (gli “scioperi a rovescio”, cioè il lavoro autogestito per realizzare opere ritenute necessarie), e ritenuta impropria dallo stesso Partito Comunista, che vedeva messa in discussione la propria funzione strategica. Questa scelta della Cgil permise in diverse aree del Paese di affrontare ritardi epocali (dall’assenza dei servizi igienici in tante case rurali all’intervento sul regime idrogeologico delle aree paludose, sino alla organizzazione di “conferenze di produzione” a livello aziendale o di comparto territoriale). L’azione rivendicativa puntava dunque ad estendere diritti e rafforzare uno sviluppo in grado di assicurare benessere a fasce crescenti di persone. Lo sviluppo dell’azione rivendicativa a livello aziendale favorì la riunificazione del movimento sindacale, dapprima nelle imprese poi, con gli anni settanta, anche a livello di Zona, con la elaborazione di piattaforme confederali per lo sviluppo dei servizi e il superamento di squilibri territoriali evidenti. Dunque ancora una volta trovò modo di esprimersi una funzione “generale” del movimento operaio, dopo la stagione dell’ingresso nell’arena democratica di masse di lavoratori prima esclusi, poi nella stagione della definizione del profilo dell’Italia repubblicana, infine con un sindacato impegnato nella connessione tra azione rivendicativa e politiche di sviluppo.
La stagione del terrorismo confermò questo ruolo, con un Luciano Lama attento nella difesa delle istituzioni democratiche da una doppia aggressione: dalle forze che tentavano una improponibile rivincita della destra eversiva contro le sinistre ed il sindacato, e da chi volle combattere le istituzioni repubblicane in nome di una rappresentanza del lavoro “tradita” dalla presenza delle grandi confederazioni.
Con gli anni ’80 apparve chiaro che la stagione del dopoguerra volgeva al termine, in Italia e non solo. Nel dibattito politico si cominciò a fare riferimento all’esigenza di riconoscere la “centralità delle imprese”, affermandone dunque l’egemonia sulle stesse Istituzioni democratiche. La competizione tra i sistemi capitalistici ed i sistemi “socialisti” vide la netta affermazione dei primi ed il crollo dei secondi, travolgendo anche le culture politiche che quella competizione avevano animato. Le forze liberali e democratiche che nei decenni precedenti si ispiravano alla Costituzione sposarono senza riserve le critiche alla Carta implicite nell’ideologia neo-liberista (spingendo dunque per ridurre la responsabilità pubblica e ridimensionare il ruolo del movimento sindacale). Il Partito Comunista fu chiamato a rielaborare la propria identità e con questa anche le proprie opzioni programmatiche. Nella Cgil l’annuncio di una nuova stagione, assai diversa da quella vissuta nel dopoguerra, portò ad un confronto interno non sempre trasparente ed assai inquieto, sino alla attribuzione della prima responsabilità ad un dirigente come Bruno Trentin, non solo per il ruolo da lui giocato negli anni di più intensa contrattazione aziendale e nazionale, ma anche per la necessità di aggiornare profilo politico e ruolo sociale del “sindacato generale”. L’approvazione, nel 1991, del “Programma Fondamentale” dell’organizzazione rese evidente questo tentativo. Con il superamento del sindacato delle “componenti” la CGIL creò le condizioni per non essere travolta dal crollo dei partiti nati con la caduta del fascismo. E con l’affermazione della natura “programmatica” del sindacato si tentò di coniugare attività rivendicativa e azione riformatrice nella società. Una azione riformatrice assunta nella consapevolezza dell’importanza del rapporto tra l’azione contrattuale nei luoghi di lavoro e l’affermazione dei diritti di cittadinanza nella società. E questo non solo perché ogni lavoratore è anche un cittadino, ma anche perché la ricerca del riconoscimento dei diritti della “persona” (non di una “classe”) nel lavoro, comprende la spinta alla libertà ed all’autonomia nel contesto di una organizzazione del lavoro che tende a non riconoscere le opinioni, gli affetti, l’aspirazione alla crescita culturale, alla tutela della salute, alla dignità. La spinta, in altre parole, a non essere considerati “merce” (oggetto misurabile in termini di valore) ma persona, cittadino tutelato dalla Costituzione.
In questa linea di lavoro si collocò la pressione (sino allo sciopero generale) per il diritto alla casa, inizialmente sostenuto dalle Confederazioni e dalle categorie degli edili e poi approdato ad una rappresentanza non più limitata ai lavoratori dipendenti con la creazione Sunia (1972); la scelta di riformare la rappresentanza dei pensionati da un sindacato di categoria “verticale” (la Federazione Italiana Pensionati, F.I.P.) ad un sindacato “orizzontale”, cioè fondato su Leghe territoriali impegnate nella affermazione di sistemi di welfare universale (dal 1977 “Sindacato Pensionati Italiani”, SPI); la pressione forte per la riforma sanitaria (ottenuta nel 1978, con il superamento delle mutue). Infine, con la definizione della Cgil come sindacato “dei diritti e della solidarietà”, la decisione di dare corpo ad un’altra esigenza non riconducibile alla condizione lavorativa: quella del diritto/dovere alla cittadinanza attiva, con la creazione dell’Auser (1989), per assicurare qualità ai contesti di vita e valorizzare al di fuori della sfera produttiva la risorsa umana generata dall’aumento della longevità e favorire lo sviluppo di pratiche solidali e civiche.
Questo arricchimento della rappresentanza confederale non sarebbe stato completo senza una ridefinizione della stessa democrazia interna all’organizzazione, nei luoghi di lavoro, nelle categorie e nella Camere del Lavoro. Si precisarono così i diritti degli iscritti, le prerogative degli organismi dirigenti, le regole democratiche per orientarle verso le solidarietà, riducendo il più possibile le tendenze corporative inevitabili in una organizzazione per categorie.
Questo processo di “autoriforma” rappresentò un tentativo ambizioso per la rigenerazione di una organizzazione fortemente investita dai cambiamenti politici, professionali, tecnologici, e da processi di globalizzazione che sollecitavano da una parte la creazione di sovranità sovra-nazionali (a partire dalla scelta europea) e dall’altra di nuovi poteri locali fondati sulla partecipazione (malamente rappresentati dal fuorviante dibattito sul federalismo promosso dalla Lega Nord). Un tentativo ambizioso e vitale, che si scontrò con il conflitto sociale generato dall’affermazione delle politiche neo-liberiste, non a caso emblematicamente rivolte alla cancellazione del principio per cui ogni licenziamento dovrebbe essere motivato da ragioni oggettive. Sergio Cofferati si ritrovò così a gestire una difficile battaglia difensiva, per salvaguardare le tutele conquistate nei decenni precedenti ed impedire che solo i lavoratori fossero chiamati a contribuire al risanamento del bilancio pubblico con un taglio spropositato delle aspettative pensionistiche. La Cgil mostrò la capacità di mobilitazione straordinaria del sindacato, ed in una prima fase fu in grado anche di ottenere risultati significativi. Ma di fronte al nuovo quadro politico, alle fratture nell’unità sindacale che questo favorì, ed alle trasformazioni profonde nell’apparato produttivo e nei servizi, l’autoriforma della Cgil si arenò. Epifani prima, Camusso poi, non furono in grado di riprendere il cammino indicato da Bruno Trentin. La stessa scelta di Susanna Camusso di promuovere un nuovo “Piano del Lavoro” per affrontare gli evidenti ritardi causati al Paese della scelta delle classi dirigenti di rilanciare la competitività (nel nuovo contesto dato dalla adozione dell’Euro) con una progressiva svalutazione del lavoro si è dimostrata impotente. Il sindacato non era più in grado di esercitare quella funzione “generale” che nel corso della sua storia aveva più volte affermato. Emergevano con chiarezza i limiti di una organizzazione ormai incapace di rendere visibile l’alleanza tra lavoratori occupati e disoccupati (a differenza di quanto accadde negli anni ’50), e la stessa sollecitazione per lo sviluppo di una contrattazione “inclusiva” fece fatica ad affermarsi, a dimostrazione di una autoreferenzialità delle categorie impensabile nel passato.
Insomma, era cambiato il Paese, ma era anche cambiato il sindacato. Ancora negli anni ’70, nonostante il forte sviluppo della contrattazione nazionale e nei luoghi di lavoro, nella Cgil era evidente la centralità delle Camere del Lavoro: erano presenti in tutti i Comuni (anche nei più piccoli), protagoniste di ogni mobilitazione e depositarie delle risorse anche economiche del sindacato. Con gli anni ’80 questa centralità è stata via via assunta dalle categorie, con un indubbio ridimensionamento della confederalità. Secondo: l’insediamento del sindacato confederale passava da una presenza molto radicata nel territorio, nelle piccole aziende, nel lavoro diffuso, ad una concentrata in una parte delle imprese e nella pubblica amministrazione. E le Leghe dei pensionati, dopo una prima fase di forte sviluppo e radicamento locale, avviavano processi di accentramento. Terzo. Anche la rappresentanza del lavoro cambiava. La capacità di coinvolgere i lavoratori più professionalizzati (sino a farne dei veri dirigenti sindacali nei luoghi di lavoro) si affievoliva, e nella vertenzialità il “sapere” dei lavoratori più esperti e competenti era via via sostituito dal contributo di “funzionari” esterni all’impresa e con tutt’altra formazione. Quarto. Le crescenti difficoltà nella contrattazione collettiva dell’organizzazione del lavoro e dei trattamenti economici cambiavano i percorsi di sindacalizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici. La “scoperta” dell’importanza dell’organizzazione sindacale avveniva in passato nel corso di lotte collettive per migliorare la propria condizione, dagli anni ottanta si manifestò nelle lotte per difendere il posto di lavoro e nella ricerca di tutele (spesso individuali) per i diritti contrattuali e previdenziali. Tutele che non sono affatto estranee alla rappresentanza sindacale, ma che ben raramente alimentano una contrattazione collettiva per il miglioramento delle condizioni di lavoro.
So bene che, poste in questi termini, queste osservazioni possono apparire sin troppo crude, e in qualche realtà anche discutibili, ma credo che se si vuole ricostruire una capacità di intervento “dal basso” sulle condizioni di lavoro e di cittadinanza il movimento sindacale (e la Cgil in particolare) debba affrontare questi nodi. L’alternativa è nella progressiva perdita di forza nelle imprese private e nella affermazione di una funzione “confederale” molto leggera, analoga a quella affermatasi in altri Paesi europei. Una funzione non inutile, ma certo lontana dalle aspirazioni che hanno fatto nascere e poi crescere la Confederazione Generale del Lavoro in Italia: un sindacato molto rappresentativo, capace di coniugare l’iniziativa per il miglioramento delle condizioni del lavoro con quella per lo sviluppo dell’intero Paese, e dunque con un ruolo politico evidente ma ben distinto dal ruolo dei partiti politici.
Io non credo che quanto accaduto fosse ineluttabile, mi chiedo anzi se non abbiano pesato errori e ritardi nella comprensione di come cambia il lavoro, e quindi di come l’organizzazione che intende valorizzarne il ruolo deve agire. Ed avanzo alcune ipotesi.
Sul primo punto: il recupero della “centralità” delle Camere Confederali del lavoro rispetto alle dinamiche sociali nel territorio ed a sostegno di una democrazia sostanziale (cioè non riservata al solo esercizio dei diritti politici al di fuori del rapporto di lavoro). Un recupero che più volte Maurizio Landini ha richiamato come essenziale, ma sul quale non si è ancora sviluppato un effettivo confronto all’interno del sindacato. È evidente che non potrà affermarsi un ruolo “generale” della rappresentanza del lavoro se questa vive soprattutto in una dimensione “categoriale” (o peggio ancora corporativa). Il vecchio assetto fordista, che per offrire produzioni di massa standardizzava sia i prodotti che le comunità (spesso assai omogenee per effetto dell’influenza della condizione professionale prevalente) è ormai ampiamente superato. Non che sia scomparsa la vecchia organizzazione del lavoro taylorista (soprattutto in alcune attività), ma è evidente come l’attuale società sia caratterizzata da una grande varietà di condizioni sociali e professionali, che alimentano una forte spinta all’individualismo ed alla corporativizzazione. In questo contesto i rischi di una contrapposizione tra diritti nel lavoro e diritti di cittadinanza si moltiplicano, soprattutto nelle attività di servizio (pubblico o privato che sia), ma non solo. E l’applicazione di sistemi contrattuali che favoriscono la frantumazione invece di assicurare tutele “universali” aggravano questa tendenza. Tanto più se questo sistema contrattuale è avulso da ogni verifica della rappresentatività dei contraenti. È importante che il movimento sindacale recuperi la capacità di sviluppare una rappresentanza capace di abbracciare sia le condizioni lavorative più deprivate che quelle più centrali nell’attuale modello di sviluppo, e che riesca a proporre una “alleanza” con condizioni sociali non determinate dal rapporto di lavoro ma ugualmente mortificate dalle dinamiche economiche dominanti. Senza questa attenzione nel sindacato si afferma il punto di vista di una parte soltanto dei soggetti a scapito di altri, magari ancora più esposti ed in difficoltà. Nel movimento sindacale degli albori, in una società che non riconosceva alcun diritto di cittadinanza, il lavoro sindacale era accompagnata dallo sviluppo di forme di mutualismo e di auto-organizzazione che cercavano di offrire risposte concrete a sostegno delle condizioni di vita. Così si migliorava la condizione delle persone e si rafforzava l’autorevolezza delle rappresentanze sociali e politiche. Oggi associazionismo e cooperazione si sono molto sviluppate e diversificate, sentono con forza la propria autonomia, spesso sottovalutano le esigenze ed il valore del lavoro. Al punto che non mancano comportamenti parassitari generati dalle normative che favoriscono la svalutazione del valore del lavoro. Accade così, ad esempio, che la Cgil solleciti una “programmazione partecipata” per l’individuazione di investimenti in risposta a bisogni sociali o produttivi, ma che poi sia il “terzo settore” a partecipare ai “tavoli di co-programmazione”. E che i due soggetti non si parlino. O si guardino con ostilità. Ancora: accade che il sistema contrattuale riconosca alle rappresentanze sindacali i diritti di informazione e percorsi di confronto sui processi di ristrutturazione, ma che poi la legislazione riconosca solo ad altri (nella pubblica amministrazione) la possibilità di accedere ai “tavoli” di co-progettazione per la realizzazione di determinati obiettivi. È evidente che se la rappresentanza del lavoro esercita una attività esclusivamente rivendicativa e conflittuale, estraniandosi dai contesti cooperativi e partecipativi, la stessa contrattazione rischia di ridursi ad una funzione difensiva.
Penso dunque che le Camere del Lavoro debbano recuperare l’idea di una collaborazione tra contrattazione e mutualismo, favorendo mediazioni che portino a parlare con una voce unica all’interno del sistema economico e delle Istituzioni. Se questo non accade, la stessa contrattazione sociale territoriale resterà confinata ad una funzione subalterna, ed il recupero di una funzione “generale” non potrà affermarsi perché la confederalità sarà ridotta alla funzione (spesso assai debole) di coordinamento tra le categorie.
Sul secondo punto, l’insediamento del sindacato confederale. Nel passato questo ha risentito del passaggio da un apparato produttivo radicato localmente ad uno sempre più de-localizzato grazie allo sviluppo di tecnologie dell’informazione sempre più efficienti. In futuro questo processo non si invertirà, e la capacità del sindacato di radicarsi nel nuovo mondo dovrà affermarsi a prescindere dalla presenza di controparti “fisiche”. La prima sfida che deve dunque affrontare è nella sua capacità di interpretare condizioni di lavoro in costante trasformazione, ampiamente individualizzate e spesso collocate in contesti virtuali. Condizioni di lavoro nelle quali il rapporto tra l’autonomia riconosciuta al prestatore d’opera ed i sistemi di controllo amministrativo e gerarchico cambiano radicalmente rispetto alla tradizione novecentesca. Già ora non è sempre facile individuare l’origine dei vincoli imposti al lavoratore, ed anche i vecchi confini tra lavoro dipendente e lavoro autonomo appaiono più evanescenti, si moltiplicano infatti attività eterodirette ma caratterizzate da una crescente capacità di decisione del lavoratore, ed attività “autonome” in realtà predeterminate in ogni particolare dalla committenza. La scelta della Cgil di puntare ad uno Statuto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori fondato non sulla appartenenza ad un determinato contesto contrattuale ma sulla condizione soggettiva di persona che lavora, è dunque strategica. Ma la rappresentanza di questa nuova condizione lavorativa deve essere accompagnata anche da una revisione della cultura sindacale, altrimenti non riuscirà a promuovere una rappresentanza collettiva ugualmente “universale”. Ancora una volta il pensiero di Bruno Trentin, ne “La città del lavoro”, ci aiuta. Ci fa infatti notare come il lavoro chiamato a “pensare” quel che fa (e non solo a “fare”), il lavoro creativo, di ricerca e sviluppo (mentre la produzione é e sarà sempre più automatizzata), il lavoro di cura (delle persone e dell’ambiente), il lavoro educativo e pedagogico (non tutto racchiuso nelle scuole) non può essere interpretato guardando solo alla costrizione, all’alienazione, e al “conflitto”. Questo è un lavoro che produce anche identificazione, che sollecita cooperazione, che richiede partecipazione e condivisione. Ciò non significa che manchino conflitti, espliciti o potenziali, ma semplicemente che non ci sono solo questi. La contraddizione che in molte attività ha portato al superamento del taylorismo (tra l’esigenza di un lavoratore “che pensa” ed un sistema che non riconosce il pensiero del lavoratore) pesa dunque anche per il sindacato, che deve prendere atto che quando il lavoro arricchisce l’identità personale la sua rappresentanza non può affermarsi solo attraverso il conflitto, ha bisogno anche di offrire sostegni all’esperienza ed alla libertà personale. Si tratta insomma di prendere atto che il lavoro moderno non è solo “alienazione” (mancanza di libertà, scissione tra la volontà personale ed organizzazione gerarchica del lavoro), è anche crescita individuale, autorealizzazione, esperienza in divenire, acquisizione di competenze. E dunque chiede anche sviluppo della professionalità, rispetto per l’identità acquisita, sostegno nella ricerca del riconoscimento del ruolo assunto. Nella mia esperienza ho viva la memoria di come sia cresciuto il sindacato scuola della Cgil di Modena negli anni ’90, passando da circa 1800 iscritti a quasi 3600: sviluppò la propria azione su tre livelli: la contrattazione collettiva, la tutela individuale e la formazione professionale. Nello stesso periodo altre categorie (o la stessa in altri territori) non sviluppando questa “terza dimensione”, e qualche volta sottovalutando persino la seconda, arrancavano o perdevano iscritti.
Questa strategia risponde anche al terzo punto di crisi: la perdita di contatto con i lavoratori più professionalizzati. Un fenomeno che ha avuto inizio negli anni ’70, quando si imputò la perdita di rappresentatività del sindacato nelle alte professionalità all’appiattimento retributivo indotto dal sistema di indicizzazione dei salari in un contesto di alta inflazione. La soluzione adottata (il superamento della scala mobile e lo sviluppo della contrattazione) non ha risolto il problema, non solo perché le alte professionalità hanno diversi strumenti con i quali ottenere il riconoscimento delle proprie competenze, ma anche perché l’investimento nella propria professionalità sollecita una partecipazione al lavoro che include l’autorealizzazione, e dunque non viene vissuta solo come conflitto. Per queste figure il senso di alienazione (ben presente nelle mansioni più esecutive e deresponsabilizzate) é sostituito dal rafforzamento dell’identità e dall’orgoglio per la crescita di esperienza e professionalità. Un sindacato che in queste figure veda essenzialmente una funzione “gerarchica”, ne consideri in termini negativi la capacità di contrattazione individuale, e che dunque sia portato a collocarle tra le “controparti” o i “crumiri”, ben difficilmente potrà sviluppare con loro una relazione positiva che giunga sino ad ottenere il loro contributo nella contrattazione di una organizzazione del lavoro più partecipata e meno alienante.
E così si giunge al quarto punto di crisi: la riduzione del sindacato da soggetto orientato alla conquista di spazi di libertà e di dignità personale, a protagonista di una tutela difensiva (dunque comunque perdente). Una funzione certo favorita dai profondi cambiamenti strutturali cui abbiamo già fatto cenno (le modificazioni tecnologiche e nell’organizzazione del lavoro, la forza di una globalizzazione che mette in concorrenza condizioni di vita incomparabili, la spersonalizzazione del “padrone” sostituito da aggregati finanziari complessi…), ma dalla quale non si potrà uscire senza un recupero della capacità dei lavoratori di intervenire sulle strategie d’impresa.
Questo recupero avrà bisogno dell’apporto della politica, cioè della regolazione dei mercati e dei poteri dei soggetti in campo (come ha ben compreso Pierluigi Bersani). Ma la politica ha bisogno di una partecipazione “dal basso” che assicuri spinta e coerenza nelle decisioni. Impulsi che, in assenza di organizzazioni in grado di elaborare strategie autonome ed ampiamente condivise, non potranno che essere in sintonia con il “senso comune” indotto dai poteri forti ed egemoni. Eccoci. Siamo nel cortocircuito che blocca la sinistra politica e la rappresentanza sindacale.
Assunta l’idea che in futuro il lavoro non scomparirà, possiamo dare per certo che si diversificherà ancora. Che vedrà convivere (sia nel lavoro produttivo che nelle attività di servizio e di cura) “vecchie” prestazioni caratterizzate da subordinazione ad un datore di lavoro e nuove relazioni contrattuali di tipo individuale. Le mansioni ripetitive e senza spazi decisionali saranno via via automatizzate, mentre quelle più caratterizzate da margini di autonomia, originalità, creatività saranno regolate da sistemi contrattuali che accanto ad una (auspicabile) base di diritti universali definiranno le modalità di partecipazione al lavoro ed i risultati attesi di quella persona. Dunque aumenteranno le forme di lavoro capaci di incidere sulla identità personale, sugli spazi di autorealizzazione, di “libertà” (intesa come autonomia delle scelte e nella definizione dei tempi di realizzazione). Torno dunque alla domanda iniziale: ci sarà spazio, in un mondo così, per un sindacato “generale”? Cioè impegnato nella rappresentanza e nella promozione di un lavoro che ottenendo libertà ed equità aumenti la libertà e l’equità per l’intera società?
Mi pare evidente che il vecchio sindacato “di classe”, fondato sulla presenza di moltitudini accomunate dalla stessa condizione di lavoro e di vita, sarà lontano dalla percezione e dall’esperienza di chi vivrà in futuro del proprio lavoro. Ma anche il sindacato “di categoria” si ritroverà confinato in spazi limitati, perché il moltiplicarsi delle condizioni di lavoro e di vita renderà anche l’approccio corporativo un approccio limitato. E l’alleanza tra diverse categorie nell’ambito di una Confederazione potrà aumentarne il peso, ma nel contesto di una funzione tutto sommato marginale rispetto al grande tema della qualità dello sviluppo. Dunque credo che se non si riuscirà a fare il salto verso un sindacato davvero rappresentativo e capace di aggregare le persone facendone valere diritti ed aspirazioni al di là della tipologia del contratto (pubblico o privato, personale o collettivo), il sistema economico avrà più energia nel trascinare anche il sistema politico alla restrizione dei margini di libertà, dovendo negare l’insostenibilità delle differenze economiche, sociali ed ambientali.
Ricostruire radici forti nel lavoro, con un sindacato capace di rappresentarne l’effettiva condizione e di avanzare proposte unificanti, è la condizione necessaria affinché una politica volta all’equità ed alla sostenibilità sociale (oltre che ambientale) abbia la forza per “liberarsi” dalle regole competitive del “mercato”, cioè del potere del più forte. Non so quanto questo soggetto di rappresentanza somiglierà ai sindacati novecenteschi, certo resta l’esigenza di una organizzazione capace di assolvere la stessa funzione esercitata dal “sindacato generale” nel secolo scorso: fare in modo che chi non ha diritti li ottenga, che anche “gli ultimi” possano dire la loro, e che la loro partecipazione non subalterna aiuti la libertà di tutti.